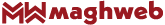Il progetto di partecipazione Elephant Talk, in questi mesi ha portato una rete di realtà europee a interrogarsi e a sperimentare pratiche e metodologie sull’approccio umanistico alla raccolta e alla rappresentazione dei dati e sul loro utilizzo come strumenti di trasformazione sociale e di sensibilizzazione.
Dopo un percorso di formazione sulla loro produzione in chiave transfemminista e intersezionale, e sul loro uso come strumenti di consapevolezza, advocacy ed educazione, i partner di progetto hanno lavorato insieme alla creazione di una survey e alla strutturazione di focus group per il coinvolgimento di giovani che vivono in Italia, Croazia, Romania, Portogallo, Grecia, Slovenia e Spagna in una indagine sul fenomeno sistemico dell’odio di genere e del body shaming online.
Comprendere questi fenomeni sistemici è fondamentale per sviluppare strategie efficaci di contrasto. E proprio in questa direzione i dati giocano un ruolo centrale, perché possono offrirci una fotografia del problema ed essere uno strumento concreto nel campo della ricerca, della promozione di politiche pubbliche efficaci e nello sviluppo di coinvolgenti campagne di sensibilizzazione.
Tuttavia, affinché i dati raccolti siano davvero rappresentativi e si possano ridurre al minimo i bias, è necessario che siano raccolti in modo partecipativo, aperto e accessibile, coinvolgendo direttamente le persone che hanno in modi diversi conosciuto da vicino queste forme di violenza digitale. Come scrivono le autrici di Data Feminism, Catherine D’Ignazio e Lauren F. Klein, una raccolta che parte da una prospettiva intersezionale deve tenere conto non solo del genere, ma includere ogni tipo di soggettività marginalizzata o che abbia subito e subisce forme di oppressione. I dati non sono mai neutri, raccontano le esperienze e le conoscenze del gruppo di persone che li ha raccolti, analizzati e comunicati.
L’approccio partecipativo, perciò, è proprio uno degli elementi alla base della raccolta dati che abbiamo scelto di condurre, perché possano essere superate le tradizionali barriere della ricerca e della raccolta, a volte distanti dalle esperienze reali di tutte le persone. Attraverso un processo di co-creazione, che ha visto il coinvolgimento di attivist3, espert3 nel campo della raccolta e della visualizzazione dei dati, ma soprattutto di adolescenti e giovani che stanno collaborando alla ricerca, l’obiettivo è costruire una conoscenza condivisa del fenomeno, capace di rifletterne le complessità.
Per questa ragione, nello sviluppo della survey di Elephant Talk, e nella costruzione della metodologia che ne sta alla base, abbiamo voluto non limitarci alla semplice raccolta dei numeri, per provare a restituire uno spaccato qualitativo di singole esperienze e strumenti di difesa o tutela dal fenomeno sistemico del body shaming e più in generale dell’odio di genere sul web.
Attraverso domande aperte e rappresentative della varietà di situazioni vissute, la raccolta terrà conto delle diverse prospettive e sensibilità. L’obiettivo è far emergere anche l’impatto emotivo, le dinamiche con cui si manifestano i fenomeni d’odio online rivolti alle donne e alle categorie marginalizzate e le risposte individuali e collettive a questa violenza. Al percorso di ricerca e analisi seguirà la loro diffusione, trasparente e quanto più accessibile, che proverà ad offrire a ricercator3, decisor3 politich3, organizzazioni della società civile, istituzioni educative e insegnanti strumenti concreti per agire e comprendere il fenomeno. Dall’analisi dei dati, che verranno condivisi con la collettività, potranno inoltre nascere campagne di sensibilizzazione, protocolli di intervento e strategie di supporto per contrastare le forme di odio e discriminazione di genere che si diffondono nei nostri spazi digitali.
Scarica la metodologia: www.maghweb.org/wp-content/uploads/2025/02/Methodology.pdf
A participatory approach for an understanding of gender hate and online body shaming
The Elephant Talk is a participatory project that in recent months has led a network of European entities to question and experiment with practices and methodologies on the humanistic approach to data collection and representation, and their use as both social transformative and awareness raising tools.
After training on how to create the tools from a transfeminist and intersectional perspective, as well as their use as tools for awareness, advocacy, and education, the project partners worked together to create a survey and structure focus groups to engage young people living in Italy, Croatia, Romania, Portugal, Greece, Slovenia, and Spain in an investigation of the systemic phenomenon of online gender hatred and body shaming.
The understanding of these systemic phenomena is critical to developing concrete and impacting strategies that contrast them. And it is in this direction that data play a central role, because they can provide us with a snapshot of the problem and be a substantial tool in the field of research, promotion of effective public policies and development of engaging awareness campaigns.
However, in order for the data collected to be truly representative and for bias to be minimized, the process of data collection needs to pass through a participatory, open, and accessible method: directly involving people who have in different ways experienced these forms of digital violence up close. As the authors of Data Feminism, Catherine D’Ignazio and Lauren F. Klein, write, a collection that starts from an intersectional perspective must take into account not only gender, but include all kinds of marginalized subjectivities or those who have experienced and are experiencing forms of oppression. Indeed, data are never neutral; they tell of the experiences and knowledge of whom collected, analyzed, and communicated them.
The participatory approach, therefore, is precisely one of the elements behind the data collection we have chosen to conduct, so that the traditional barriers of research and collection, which are sometimes distant from the real experiences of all people, can be more cushioned. Through a process of co-creation, which has involved activist, experts in the field of data collection and visualization, but especially teenagers and young people who are collaborating in the research, the goal is to build a more collective shared knowledge of the phenomenon, capable of reflecting its complexities.
For this reason, in developing the Elephant Talk survey and constructing the methodology behind it, we wanted to go beyond the simple collection of numbers, to try to return a qualitative cross-section of individual experiences and tools of self-defense or protection from the systemic phenomenon of body shaming and more generally of gender hatred on the web.
Through open-ended questions wanting to represent the variety of situations experienced, the participatory collection will take into account different perspectives and sensitivities. The goal is also to recognize and name the emotional impact and the dynamics through which online hate phenomena aimed at women and marginalized categories are manifested, and the individual and collective responses to this violence. The path of research and analysis will be followed by as much transparent and accessible dissemination which will try to offer researchers, policy makers, civil society organizations, educational institutions and teachers, concrete tools to act and understand the phenomenon. The analysis of the data, which will be shared free of charge with the community, may also give rise to awareness campaigns, intervention protocols, and supportive strategies to counter the forms of gender hatred and discrimination that are spreading in our digital spaces.